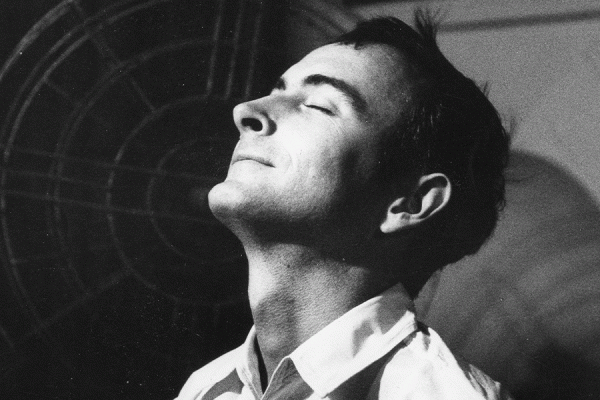Jim Jarmusch ha commesso un errore che Julian Temple è stato abilissimo ad evitare: il primo ha girato un documentario chiamato Gimme Danger che doveva essere sui The Stooges e invece è su Iggy Pop; il secondo ha girato un prodotto, Keith Richards: The origin of Species, che parla del chitarrista, della sua vita, delle sue idee, della sua infanzia, della sua famiglia e si conclude proprio con l’incontro con Jagger. Temple, leggendario regista di videoclip e “rockettaro” tanto quanto Jarmusch, alterna riprese d’archivio, foto, pubblicità, sequenze animate e Keith Richards che si racconta alla telecamera con la sua inseparabile sigaretta. Un prodotto che tiene fede al suo nome. Purtroppo, paradossalmente, è proprio la vita del leggendario chitarrista degli Stones a non essere interessante.
Niente “Sesso, droga e Rock’n’roll”, né aneddoti sugli Stones o sul suo rapporto con Jagger e nemmeno una parola sui Beatles, i loro rivali. Keith Richards racconta la sua ordinaria vita prima di diventare famoso. Nasce nel ’43 in una famiglia della middle-class britannica, sotto il segno degli ultimi bombardamenti della seconda guerra mondiale. L’infanzia la passa fra i campi martoriati e le rovine delle case distrutte, insieme agli altri bambini, giocando con quello che si trovava in giro e con “tanta immaginazione”, come dice lo stesso Richards. L’adolescenza trascorre tranquilla, fino al giorno in cui lui e un suo compagno decidono di fare di tutto per farsi espellere. Come ci riusciranno? Picchiando gli insegnanti. Nasce il Richards ribelle; muore il normale adolescente; il documentario diventa avvincente, ma, poco dopo, finisce.
È una scelta audace quella di Temple, quasi una provocazione. Girare un documentario su una della più longeve, famose e ribelli rockstar della storia e raccontarne solo l’adolescenza da borghese, trascorsa tra le case dei vicini, le partite di tennis, i sabato mattina al cinema a vedere il suo eroe Roy Rogers, le prime ragazze e le prime strimpellate di chitarra che il regista fa passare quasi inosservate. Inevitabilmente, i momenti migliori del documentario avvengono quando Keith Richards parla di musica: per esempio, per quanto riguarda Street fightin man, uno dei più grandi successi dell’album Beggars Banquet, il nostro protagonista ci confessa che quella canzone viene dal suono della sirena che segnalava il pericolo in tempi di guerra. Per il giovane Richards il suo suono è stato un trauma sin dall’infanzia, che ancora oggi non è guarito. Racconta, nel momento di più alto lirismo della pellicola, di una lontana ispirazione per Wild Horses: un magnifico cavallo che girava intorno nel quartiere, bianco e possente.
Ciò che davvero è da vedere, rivedere ed ammirare è l’abilità cinematografica di Julian Temple. Non solo ritornano le sue tradizionali sequenze animate, ma vengono riproposte tantissime vecchie pubblicità e immagini di repertorio, foto del giovane Keith Richards, video di vecchi concerti di grandi eroi musicali come Little Richard o Elvis. Le immagini, a volte, vengono addirittura proiettate sulla faccia di Richards stesso, che nel mentre fissa lo spettatore, fumando e generando una coltre di fumo che oscura lo schermo. Per tutti i circa ’90 minuti di film la musica non si ferma mia. Temple usa di tutto, da Lascia ch’io pianga di Handel a pezzi dei The verve, da Johnny Cash a Bob Dylan. Ma soprattutto, i riff più famosi di Keith Richards, alcune parti strumentali dei più grandi successi degli Stones, come la già citata Wild Horses oppure She’s like a rainbow e Simpathy for the devil.
Consigliato soprattutto ai più sfegati fan dei Rolling Stones e a chi vuole scoprire di più sulla vita meno famosa di Keith Richards. Per un documentario sulla band, si veda pure Gimme shelter, sulla cui grandezza non vi sono dubbi.

Lucca 2017: la recensione di Keith Richards – The origin of species
Il leggendario chitarrista dei Rolling Stones è il protagonista del documentario di Julian Temple, celebre regista di videoclip rock.